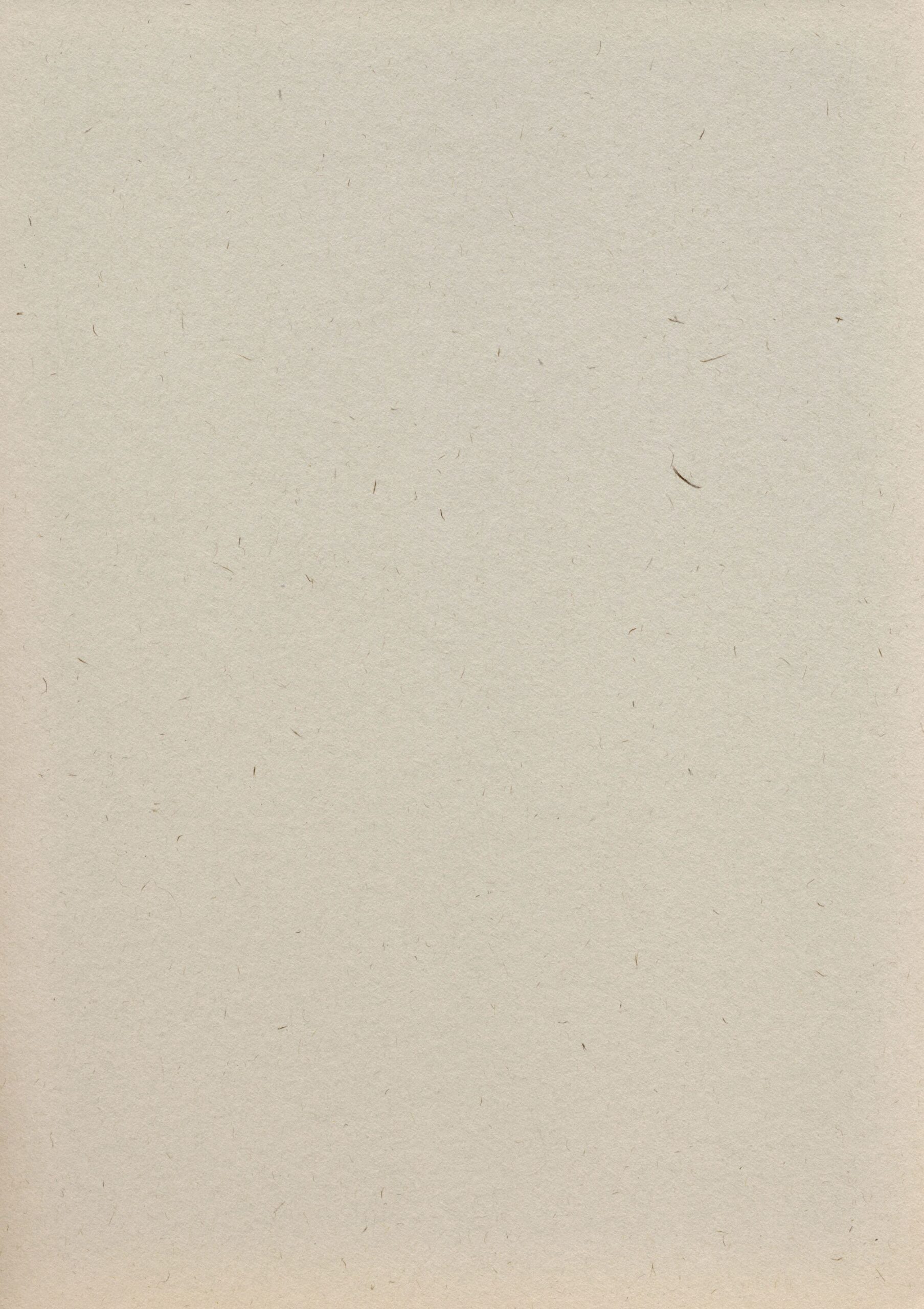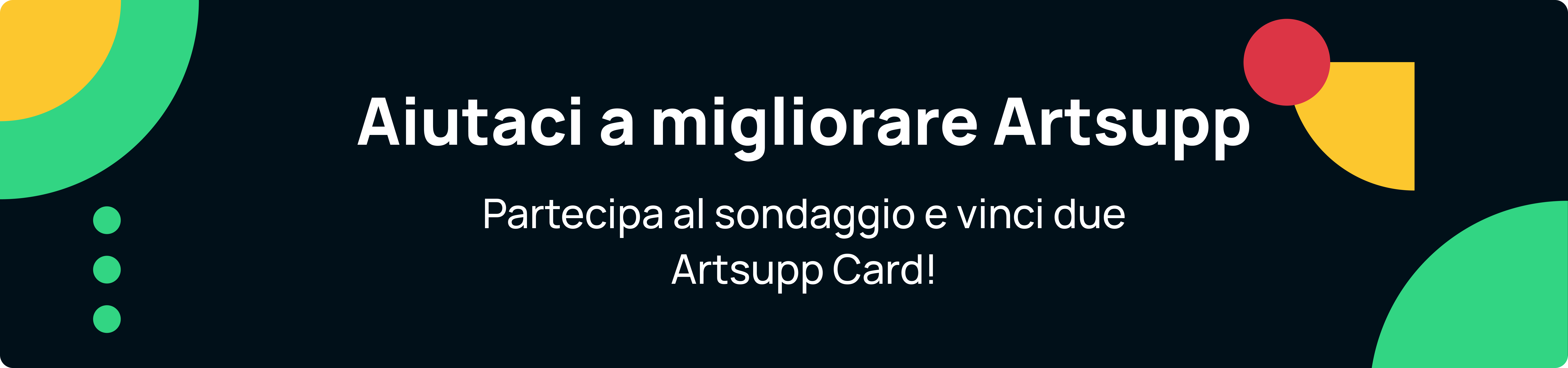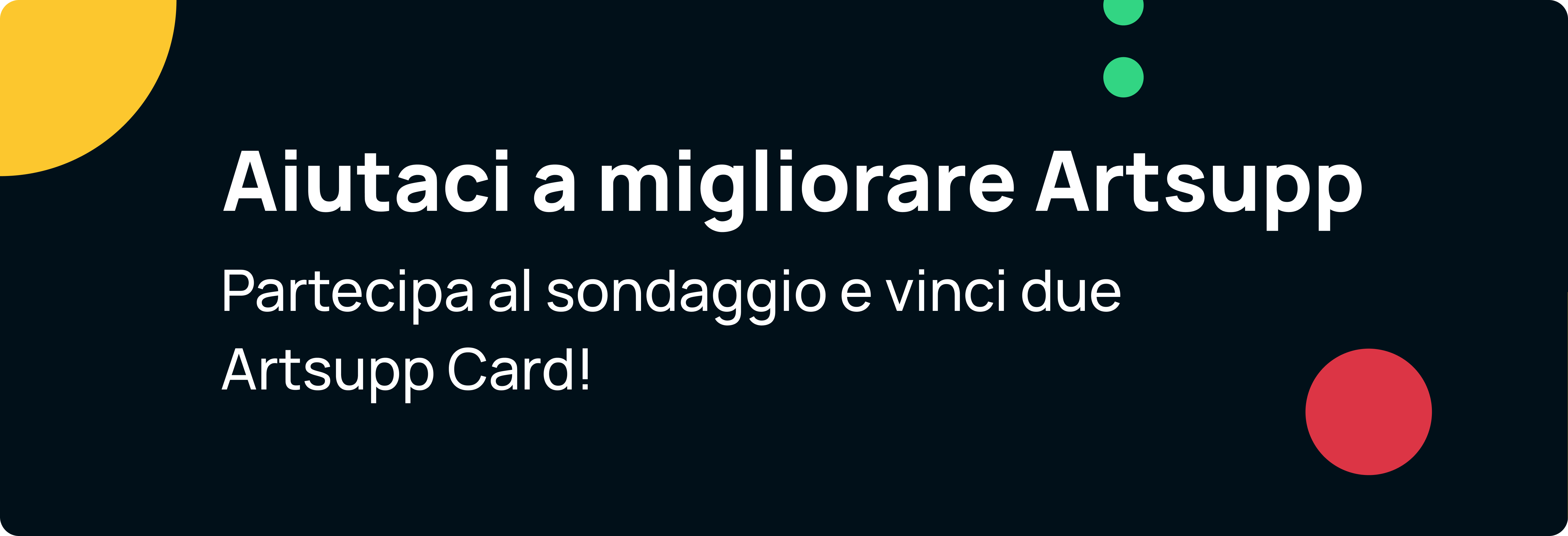Abbiamo letto, in una sua intervista, che lei si considera un po’ un erede della cultura ellenistica. Nelle sue sculture, spesso richiama miti antichi che poi rivisita. Come mai ha questa fascinazione per il mondo antico?
Mi ritengo erede della civiltà ellenistica innanzi tutto perché sono nato nel luogo geografico che è stato l’ultima tappa del lungo viaggio di conquista ed espansione verso Est di Alessandro il Macedone. Lì il grande sovrano ha lasciato una traccia non solo latente, e nella cultura popolare – dove è chiamato Eskander “dalle due corna”, dalla foggia dell’elmo che indossava – è ancora diffuso il sentimento di appartenenza a quella antica progenie.

Su un piano più legato all’eredità visuale e artistica ammetto che mi hanno sempre affascinato i residui di quella cultura antica emersi in Afghanistan (Badakhshan), Pakistan, India. Mi ricordo di essere stato sconvolto dalla scoperta di sculture del Gandhara come la testa del principe Siddharta, nella collezione di George Ortiz, dove la mano e la tecnica, il linguaggio, sono pienamente ellenici mentre sul piano antropologico non c’è dubbio che siamo davanti a una statua orientale.
Io sono etnicamente russo, ho quindi ereditato la grecità per nascita, transitata da noi anche attraverso l’Impero romano d’Oriente e in particolare attraverso la civiltà visiva bizantina. Trovo interessante, e a suo modo anche ironico, che la grande lezione classica si sia deformata dagli anni ’30 del Novecento sotto il peso dell’estetica stalinista, che dava grande valore a motivi decorativi nazionali, locali, propri alle repubbliche socialiste.

Io sono cresciuto a Biškek, che prima si chiamava Frunze, capitale del Kirghizstan, circondato da esempi plastici e architettonici di matrice classica ma rifiniti, integrati da elementi propri alla tradizione kirghiza. Non è assurdo, per esempio, trovare tutte le parti che compongono la trabeazione classica, alla sommità di un edificio nel centro di Biškek, che pur rispettando la composizione greca è ornata da motivi del mondo visivo islamico.
Esiste un detto in Russia: la storia tende a ripetersi ma la seconda volta si ripete come farsa. I comunisti, che potremmo definire pseudo-elleni, sono la seconda volta farsesca dopo la prima volta di Alessandro il Macedone, in pieno accordo con la definizione popolare! E quanto vediamo oggi potremmo chiamarlo quasi un Neo-ellenismo postmoderno.
Quanto a me, mi considero ellenista e non ellenico, per me il mondo antico non è qualcosa di esterno a cui guardare o tornare, è il mio brodo primordiale, la dimensione unica e naturale da cui provengono le mie creazioni e che vedo intorno a me come un filtro interpretativo spontaneo, che condiziona e qualifica ogni mia percezione.

Oltre alla cultura antica, ci sono altri modelli artistici da cui trae ispirazione?
Ci sono sicuramente. Ho sempre amato molto Carlo Scarpa, che considero un genio e che è per me un autentico punto di riferimento. Io sono anche architetto e la mia arte pubblica comporta una costruzione dello spazio oltre che dell’opera in sé. Carlo Scarpa mi ha insegnato a gestire la relazione tra i due aspetti, al pari delle avanguardie artistiche russe e del movimento costruttivista, che nella mia idea si lega ai successivi esiti del decostruttivismo maturato in Europa e America, qui agevolati dalla evoluzione tecnologica.
Last but not least sono un grande amante del cinema, un vero addicted, e lo ritengo una fonte potente e ricca di ispirazioni. Se penso ai miei vent’anni mi tornano in mente registi come Yasujirō Ozu o Dziga Vertov, che potrei ancora oggi guardare all’infinito, perché per me il cinema è innanzi tutto immagine, dimensione ottica e visiva, e dove la trama è il compendio di una meraviglia che cattura lo sguardo prima che l’attenzione sulla storia. Lo stesso mi sento di dire per Lars Von trier o Stanley Kubrik, i loro film per me sono sequenze di quadri.

Ho ricordi bellissimi che risalgono agli anni ’90, a Mosca, dove c’era un cinema d’essay che passava film in lingua originale, sempre vuoto, dove entravi con un biglietto dal prezzo simbolico, si chiamava Illusion ed era dentro uno dei grattacieli stalinisti. Lì ho visto per la prima volta “Citizen Kane” di Orson Welles, indimenticabile, e ripensando a quel luogo sale spontanea la definizione, oggi, di museo cinematografico.
A proposito di cinema e di Čyngyz Ajtmatov, tra i film che più hanno influenzato i miei percorsi creativi non posso non ricordare “Il primo maestro” di Andrej Končalovskij, del 1965, ispirato da un racconto del grande scrittore kirghiso.
Abbiamo notato come le montagne rappresentino per lei il legame tra uomo e natura, la stessa opera è intitolata Monte Ajtmatov. Può dirci qualcosa di più?
Come è chiaro a chi abbia letto i suoi libri o visto le sue interviste, per Ajtmatov la natura è stata sia una fonte di ispirazione che un rifugio. Molti tra i primi bolscevichi, e tra loro il padre di Čyngyz Ajtmatov, furono vittime delle repressioni staliniste. Čyngyz crebbe quindi insieme alla nonna paterna in un aiyl, cioè in un villaggio isolato sulle montagne, che nello specifico si chiamava Şeker ed era nella regione Talas; i monti sono stati il suo asilo, la sua prima patria familiare e sentimentale, lì ha vissuto la sua infanzia, maturato i primi ricordi e madre natura è stata il trampolino che lo ha lanciato nell’Olimpo della letteratura.
Quanto tutto questo sia determinante approcciando le sue narrazioni lo comprendiamo a maggior ragione pensando che aveva studiato da zootecnico, perito che nel kolchoz si occupava del bestiame. Era destinato a un ruolo amministrativo dentro una azienda agraria e invece ha fatto leva su ciò che gli era più noto e vicino, le grandi vette e il mondo naturale, per liberare la sua vera aspirazione. Inutile precisare che le montagne hanno ispirato di conseguenza anche me nella trasmissione di questa immagine di Ajtmatov.
Ajtmatov è stato uno dei principali intellettuali del suo paese e lei, per realizzare quest’opera, ha fatto anche tesoro degli incontri che ha avuto personalmente con lui. Cosa le è rimasto di più di questi colloqui? Perchè, secondo lei, coloro che non conoscono Ajimatov potrebbero avvicinarsi a lui?

Ajtmatov è il genius loci del Kirghizstan. Intellettuale internazionale negli anni ’70 e ’80, amico di scrittori europei, testimonial del nostro mondo nella vecchia Europa. Io sono cresciuto in un palazzo che era residenza per professori universitari, dove viveva anche il grande poeta kirghiso Aaly Tokambaev, amico di Ajtmatov.
Giocavo spesso con il nipote di Tokambaev e ho avutooccasione di incontrare Ajtmatov almeno un paio di volte a casa sua. Non posso però dimenticare quando – avrò avuto più o meno 12 anni – a scuola ci dissero che lo scrittore ci avrebbe fatto visita insieme al collega britannico di spy stories John Le Carrè, non stavo nella pelle, nei giorni precedenti pensavo solo a quel grande incontro, e se oggi ho dimenticato l’aspetto che in quella occasione mi fece lo scrittore inglese ricordo ancora distintamente Ajtmatov e l’impressione della sua persona, è un ricordo destinato a restare acceso per il resto della mia vita.
Sono convinto che la sua letteratura si presti molto bene alla traduzione nelle lingue occidentali. Inizialmente scriveva in kirghiso, sua lingua madre appresa e praticata vivendo insieme alla nonna, poi ha cominciato a tradurre in russo la sua stessa scrittura e infine è approdato a un russo molto costruito e strutturato.
Il linguaggio dei suoi lavori giovanili è sicuramente più semplice e adatto alla traduzione presso altre culture. Penso anche che il suo pregio fondamentale non sia quello stilistico – come in Nabokov per esempio – ma l’aspetto narrativo, l’essere intriso di un pathos umanistico che sembra scomparso dalla letteratura contemporanea, influenzata dalla politica e dal politically correct. Lui non pensava a queste cose, si concentrava sulle questioni essenziali della civiltà e dell’uomo, faceva quella che io chiamo letteratura neolitica.

Durante la sua carriera lei ha esposto in musei importanti, in Italia anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Se dovesse scegliere un museo nel mondo dove le piacerebbe esporre, quale sarebbe e perchè?

Aver esposto al Museo Archeologico di Napoli per me è stato l’avverarsi di un sogno. Amo la città di Napoli, l’ho conosciuta e ho imparato a capirla, e considero il MAN il suo museo più importante, come Maradona per la storia del calcio partenopeo!
In generale non ho come obiettivo esporre le mie opere nei musei, per me ha più significato il luogo, l’ambiente, mi piace pensare a come connotare lo spazio con la mia presenza.
Se parliamo di una mostra utile alla mia carriera di artista mi viene in mente innanzi tutto il MOMA, ma pensando ai miei desideri di creativo sarebbe straordinario poter esibire una mia statua colossale davanti al Colosseo, così che finalmente si capisca perché il Colosseo si chiama Colosseo!